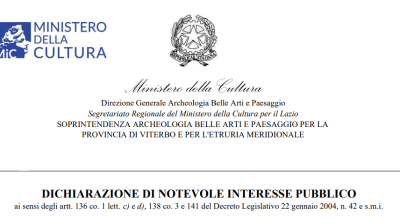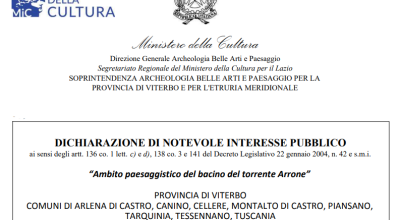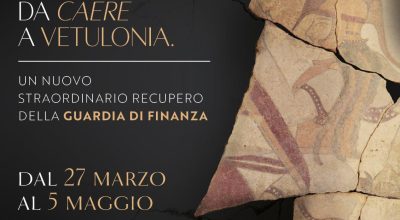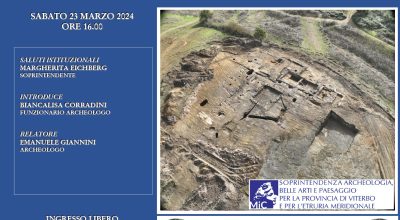AVVISO PUBBLICO di avvenuto ricevimento di proposta di sponsorizzazione: Tomba Maggi, Necropoli dei Monterozzi – Tarquinia (VT)
Ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, si rende noto che è pervenuta a questa Amministrazione, da parte di un soggetto privato internazionale, una proposta di sponsorizzazione tecnica pari a 40.000,00 euro per la realizzazione, a cura e spese dello sponsor, di un progetto di restauro conservativo ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale